Un sondaggio su oltre 5.000 professionisti restituisce un quadro tecnico dettagliato su attività, criticità e competenze degli ingegneri impegnati nel settore.

L’Italia è un museo a cielo aperto: opere architettoniche, siti archeologici, palazzi storici e chiese scandiscono il paesaggio urbano e rurale del Paese, ricordandoci l’importanza di conservare il nostro patrimonio culturale. Ma dietro ogni restauro, consolidamento o messa in sicurezza, c’è anche la mano dell’ingegnere. Una figura professionale fondamentale quando si parla di sicurezza, stabilità, innovazione e gestione tecnica.
Per approfondire il ruolo e le esigenze degli ingegneri che operano nel settore dei beni culturali e paesaggistici, è stato realizzato un sondaggio condotto dal Centro Studi della Fondazione CNI ed elaborato dal Gruppo di Lavoro “Beni Paesaggistici e Culturali – Rapporti con la Soprintendenza” del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, coordinato dal Consigliere nazionale Alberto Romagnoli.
Dalle oltre 5.000 risposte raccolte emerge un quadro articolato fatto di criticità, opportunità e prospettive per valorizzare il contributo tecnico degli ingegneri nella tutela del patrimonio culturale.
Chi sono gli ingegneri che operano nel settore
Dall’analisi delle risposte fornite da oltre 5.000 ingegneri emerge un quadro chiaro del coinvolgimento della categoria nel settore dei beni paesaggistici e culturali. La maggior parte degli intervistati (51,6%) ha dichiarato di occuparsene solo saltuariamente, mentre il 25,7% vi è attivamente impegnato. Si tratta, dunque, di un ambito ancora parzialmente esplorato dalla professione, ma con un nucleo consolidato di esperti.
Dal punto di vista anagrafico, il settore appare dominato da profili senior: tra i 3.784 ingegneri attivi nel comparto, oltre la metà ha più di 46 anni. Gli under 35 rappresentano solo il 10% del campione, evidenziando un accesso ancora limitato delle nuove generazioni.
Quanto alla formazione, il 67,4% possiede una laurea a ciclo unico, il 24,5% una magistrale e il 10,3% una triennale. I dottorati e i master di secondo livello rappresentano una minoranza (2,8% e 2,4%).
La quasi totalità degli intervistati (95%) è iscritta al settore civile e ambientale dell’Albo, ma non mancano iscrizioni multiple: il 26,5% è anche nel settore industriale e il 20,3% in quello dell’informazione. Solo il 4,8% è iscritto anche ad altri Ordini, prevalentemente come architetti (51,9%) o geometri (30,4%).
Attività e ambiti di intervento
L’attività più diffusa è la progettazione (78,2%), seguita da direzione lavori e collaudo (60,2%) e sicurezza (27,9%). Una parte più ridotta si occupa di tutela diretta dei beni (11,5%), istruttorie tecniche (11,4%) e project management (7,1%).
Gli interventi riguardano spesso edilizia residenziale (64,4%), pubblica (44,3%) e paesaggistica (35,4%), con una buona presenza anche nel campo delle infrastrutture e dell’edilizia produttiva.
Tra le procedure tecniche e amministrative più ricorrenti, spiccano la progettazione (78,2%) e le autorizzazioni paesaggistiche (76,8%), seguite da pratiche come SCIA (50,9%) e permessi a costruire (49,7%).
Formazione e aggiornamento: un nodo cruciale
Una sezione fondamentale del sondaggio è stata dedicata ai percorsi formativi e di aggiornamento, con risultati che fotografano chiaramente un'esigenza diffusa: la formazione ricevuta durante gli studi universitari viene considerata non adeguata (28,9%) o solo parzialmente adeguata (31,2%) dalla maggioranza degli ingegneri che operano nel settore dei beni culturali e paesaggistici. Solo il 13,6% del campione la ritiene pienamente coerente con le competenze necessarie per affrontare le sfide di questo ambito.
Per l'aggiornamento professionale, il 42,9% individua negli Ordini territoriali i principali referenti, mentre gli “altri percorsi” (46,4%) come il confronto con colleghi e l'uso di risorse online risultano fondamentali.
Le competenze normative (56,5%) e tecniche (55,2%) sono le più richieste, seguite da tecniche di restauro e gestione di progetti complessi.
Solo il 32,8% degli ingegneri segnala una Commissione dedicata ai beni culturali nel proprio Ordine.
Infine, la certificazione delle competenze è vista come utile dal 51,2% degli intervistati, ma solo il 30,4% la considera necessaria come requisito per operare nel settore.
Criticità e possibili soluzioni a supporto degli ingegneri
I risultati emersi dal sondaggio restituiscono un’immagine chiara e articolata del rapporto tra gli Ingegneri e il settore dei beni culturali e paesaggistici. Un ambito che, pur coinvolgendo una porzione significativa della categoria, risulta ancora segnato da criticità strutturali e operative. Le difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la frammentazione normativa e la complessità delle procedure costituiscono ostacoli ricorrenti, che rallentano il lavoro dei professionisti e ne limitano il potenziale contributo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio.
Il quadro tracciato dalle risposte rappresenta non solo una fotografia puntuale dello stato attuale, ma anche una base concreta su cui costruire proposte e interventi. Il riconoscimento del ruolo degli Ingegneri in questo ambito e la definizione di strumenti normativi, formativi e procedurali più efficaci potranno rappresentare un passo decisivo verso un sistema più efficiente, capace di valorizzare le competenze tecniche e progettuali che la professione è in grado di offrire.
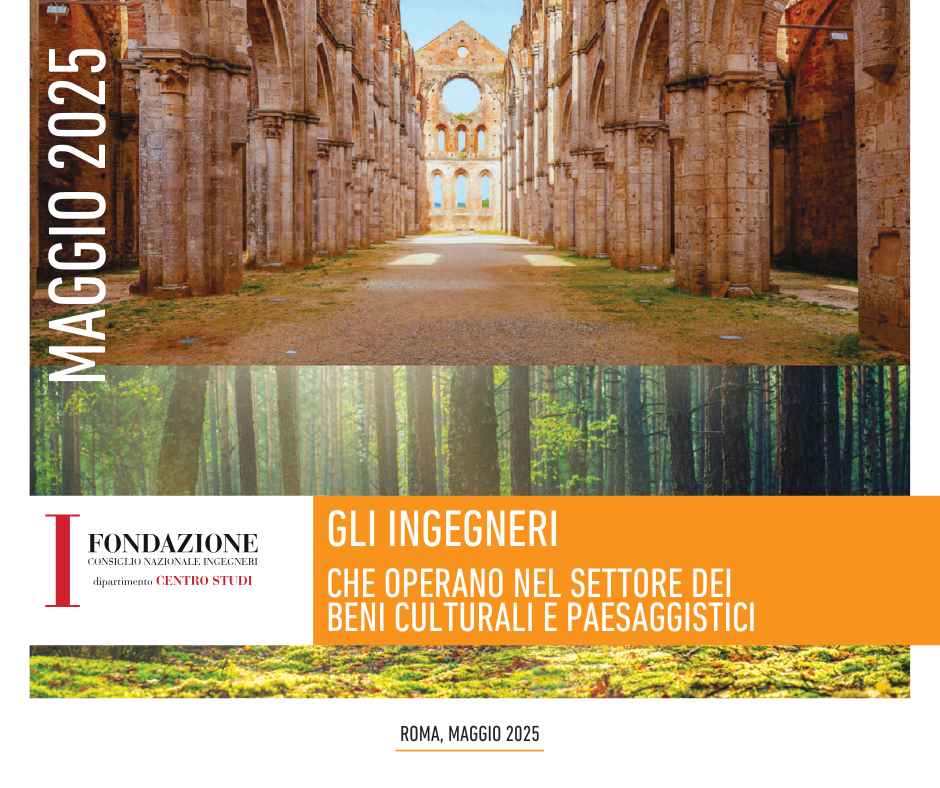
Consulta e scarica l'indagine del Centro Studi
È possibile riprodurre, distribuire, divulgare i dati purché venga citata la fonte: Elaborazione del Centro studi Fondazione CNI, 2025